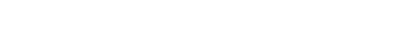Sarah Tardino è nata a Licata nel 1980, vive a Bologna. Ha pubblicato versi e prose su riviste ed è presente in diverse antologie. Si occupa di critica letteraria e storia del pensiero. È autrice di testi teatrali. Fra le sue raccolte di poesia nel 2008 è apparso per l’editore Manni Il Custode e nel 2011 per l’editore Lietocolle il poemetto I giorni della Merla. Nel 2015 l’ultima sua raccolta, L’ombrello rosso, con prefazione di Massimo Morasso, è stata da noi pubblicata nella collana “Poesia contemporanea”.
Sono il tuo testo a fronte –
è stato il sospiro, mentre aprivi gli occhi,
baciandomi la mano,
dopo il mondo salvato
dal frastuono della folle estate.
Per i tuoi battiti spaiati di strano cavaliere
combaciamo nelle pagine chiuse,
bocca sulla bocca, bocca sulla bocca,
siamo segreti dei lunghi inverni
che svaniscono col fiato,
poco prima della neve.
Resta dietro i vetri delle mie finestre,
nelle mani fredde costrette a sorprendermi.
Sul ponte ho camminato con l’inverno nel cuore
mentre tu risalivi dalle apnee
dove hai gettato tre monete e il respiro
per arrivare con un morso di sabbia
e la tosse dei lupi.
Le labbra, le labbra e i denti, più feroci...
siamo solo noi, e c’è il fuoco,
un posto che era nostro
quando ci fu data vita nelle corse,
sotto il peso di queste fragili astuzie battezzate
nelle fosse comuni dei nostri impeti di nuotatori.
È stato perché la mano ha scritto
“Ciò che non scrivo esiste”
e ha risposto la doppia lama
delle tue forze “so camminare,
ho persino gli attrezzi per farmi le ali
e volarti addosso se fai l’ape regina,
e continui a chiamare con le ciglia delle albe
dove domini il mio peso”.
Da quelle albe sorge la sciamana piumata
che abita i recessi delle mie branchie,
metà uccello e metà arcano,
e, sfrenata, sta danzando e battendo
e baratta ogni acqua cheta della sorte,
e spezza il sortilegio di ogni ragione cartesiana
per conservarti il reame
dei miei piccoli seni che sgridavo inutilmente
“siate modesti!” mentre fra loro vantavano:
“noi per primi scucimmo la festa alle sue labbra”
e il fiore nero impettito come se ne stanno le scogliere
dopo i venti del nord,
cantava: “le delizie del suo piacere sono in questo possesso”
e poi uno sciame di ninfe invase ogni luogo del corpo
che il tuo baccanale bagnava, con il suo tocco di tamburi,
finché i fianchi si dichiararono scettro
per averti dato acqua e terra
di questo regno.
Chi sono stata dimmi?
nella vita in cui la maga
dice che fummo separati da noi.
Chi ero?
Meraviglia, meraviglia, parlava
la clessidra, tu davi voce alle cose,
alle ombre,
e un gesto tuo decise tutto.
Mi scrivi che vai in cerca della luce dei fari,
con il fiuto, le mie icone con gli occhi nudi,
mentre stai assiso sopra interminabili golfi
e aspetti che una ad una ti mandi le assi di un vascello
di lettere per prendere la strada del ritorno.
è stato il sospiro, mentre aprivi gli occhi,
baciandomi la mano,
dopo il mondo salvato
dal frastuono della folle estate.
Per i tuoi battiti spaiati di strano cavaliere
combaciamo nelle pagine chiuse,
bocca sulla bocca, bocca sulla bocca,
siamo segreti dei lunghi inverni
che svaniscono col fiato,
poco prima della neve.
Resta dietro i vetri delle mie finestre,
nelle mani fredde costrette a sorprendermi.
Sul ponte ho camminato con l’inverno nel cuore
mentre tu risalivi dalle apnee
dove hai gettato tre monete e il respiro
per arrivare con un morso di sabbia
e la tosse dei lupi.
Le labbra, le labbra e i denti, più feroci...
siamo solo noi, e c’è il fuoco,
un posto che era nostro
quando ci fu data vita nelle corse,
sotto il peso di queste fragili astuzie battezzate
nelle fosse comuni dei nostri impeti di nuotatori.
È stato perché la mano ha scritto
“Ciò che non scrivo esiste”
e ha risposto la doppia lama
delle tue forze “so camminare,
ho persino gli attrezzi per farmi le ali
e volarti addosso se fai l’ape regina,
e continui a chiamare con le ciglia delle albe
dove domini il mio peso”.
Da quelle albe sorge la sciamana piumata
che abita i recessi delle mie branchie,
metà uccello e metà arcano,
e, sfrenata, sta danzando e battendo
e baratta ogni acqua cheta della sorte,
e spezza il sortilegio di ogni ragione cartesiana
per conservarti il reame
dei miei piccoli seni che sgridavo inutilmente
“siate modesti!” mentre fra loro vantavano:
“noi per primi scucimmo la festa alle sue labbra”
e il fiore nero impettito come se ne stanno le scogliere
dopo i venti del nord,
cantava: “le delizie del suo piacere sono in questo possesso”
e poi uno sciame di ninfe invase ogni luogo del corpo
che il tuo baccanale bagnava, con il suo tocco di tamburi,
finché i fianchi si dichiararono scettro
per averti dato acqua e terra
di questo regno.
Chi sono stata dimmi?
nella vita in cui la maga
dice che fummo separati da noi.
Chi ero?
Meraviglia, meraviglia, parlava
la clessidra, tu davi voce alle cose,
alle ombre,
e un gesto tuo decise tutto.
Mi scrivi che vai in cerca della luce dei fari,
con il fiuto, le mie icone con gli occhi nudi,
mentre stai assiso sopra interminabili golfi
e aspetti che una ad una ti mandi le assi di un vascello
di lettere per prendere la strada del ritorno.
Sono qui, cos’è Licata se non l’Itaca
dalla quale non mi sono mai mossa?
Perché le pareti d’argilla come un pugno chiuso
e le stanze incinte di tutti i giovani morti
che ci hanno dimenticato mentre saltavano,
ed ora sbiadiscono nei quaderni.
Perché le madri che hanno pagato la bocca alle indovine...
oh, i morti, i morti si dimenticano di noi.
Non ci appartengono.
dalla quale non mi sono mai mossa?
Perché le pareti d’argilla come un pugno chiuso
e le stanze incinte di tutti i giovani morti
che ci hanno dimenticato mentre saltavano,
ed ora sbiadiscono nei quaderni.
Perché le madri che hanno pagato la bocca alle indovine...
oh, i morti, i morti si dimenticano di noi.
Non ci appartengono.
Da: L’ombrello rosso, Raffaelli Editore 2015